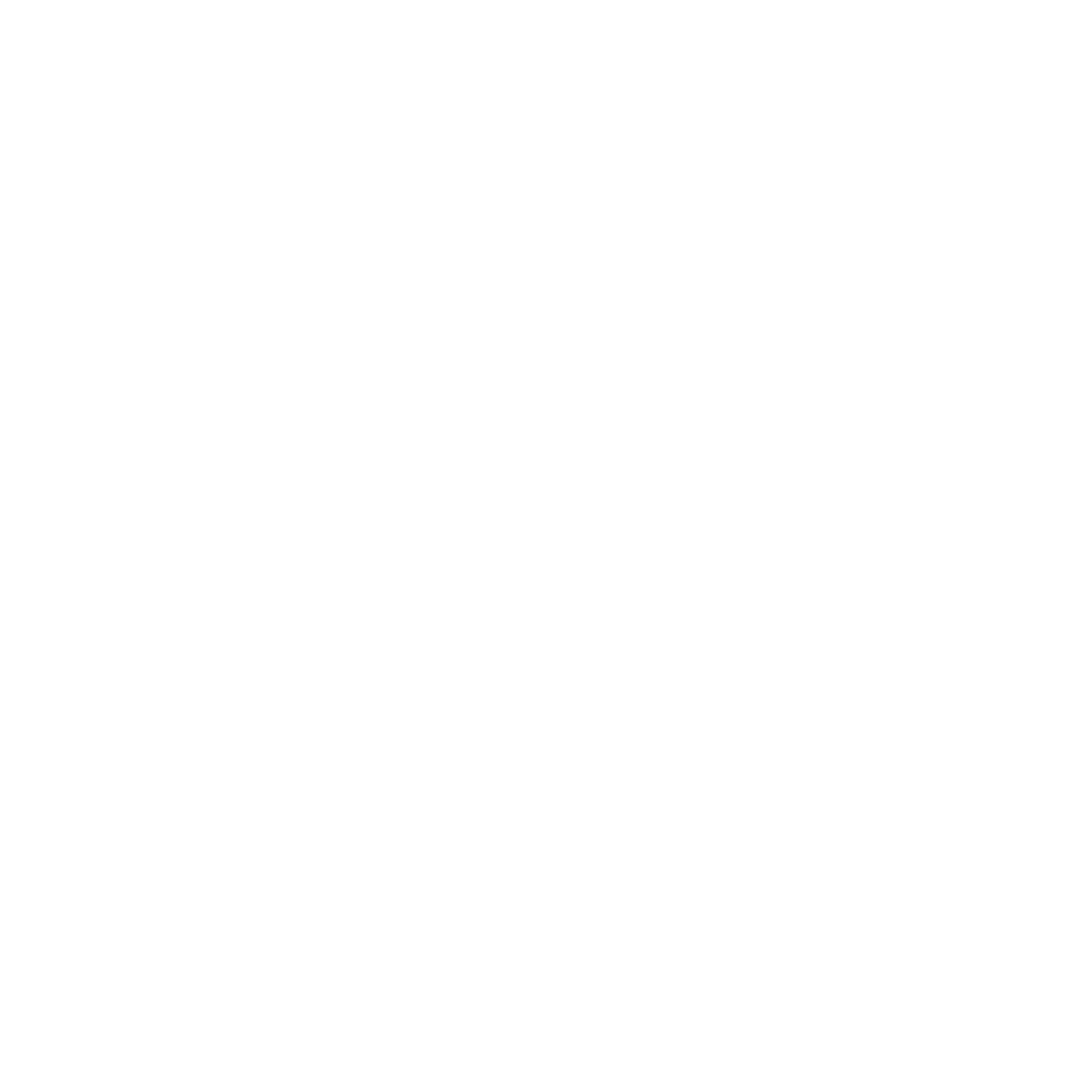"Sarebbe inutile e ridondante associarmi al già vasto coro di proteste per la gestione delle scuole durante la pandemia. Nonostante i dubbi di coloro che sostengono che non è possibile ad oggi stimare quanti e quali danni comporterà questo anno e mezzo di didattica sui generis nel futuro degli studenti, chi lavora a scuola ha già sotto gli occhi le difficoltà a cui i ragazzi sono andati incontro. Quindi passiamo oltre, per provare a gettare uno sguardo su uno spaccato scolastico particolare, spesso ritenuto marginale, come un centro di formazione professionale alberghiero. Cercherò di raccontare chi siamo e cosa abbiamo fatto finora, consapevole di non poter restituire in poche righe la complessità di una scuola che esiste da oltre sessant’anni, e anche col desiderio di non prendermi troppo sul serio, almeno di tanto in tanto.
Siamo a Ostia, davanti al mare. Già la collocazione ci aiuta non poco. Venire a scuola tutte le mattine è, nonostante le battaglie quotidiane dentro e fuori le aule, un piacere. La pandemia ci ha ovviamente colti impreparati nei primi mesi, ma non da settembre, quando eravamo decisamente più attrezzati ad affrontarla. I nostri laboratori di pratica sono rimasti sempre aperti, ogni giorno abbiamo accolto in ogni classe piccoli gruppi di studenti con disturbi dell’apprendimento, assieme ad altri loro compagni, a prescindere dal colore della regione in cui eravamo immersi; abbiamo acquistato tablet e connessione per tutti, e una piattaforma per la dad stabile ed efficiente. Non basta, è ovvio, la scuola non è questo, e certamente gli sforzi fatti non sono stati sufficienti per arginare i tanti problemi sorti, tra i quali balza agli occhi l’avanzare della dispersione scolastica, contro la quale la dad è davvero un’arma spuntata. Ciò nonostante, in mezzo alla tempesta perfetta, siamo riusciti a non smarrire del tutto la rotta. Cardini del progetto educativo emergenziale sono state l’inclusione e l’accoglienza, garantite al massimo delle nostre possibilità consentendo ai piccoli gruppi cui facevo riferimento di continuare a frequentare la scuola. Nonostante lo smarrimento e la solitudine di molti, siamo riusciti fino ad ora a sostenere la prova dignitosamente, con non meno di 40 studenti in presenza ogni giorno (la mia scuola è piccola, circa 130 studenti e 20 insegnanti).
Come è possibile far ciò? Perché una scuola piccola e periferica può assolvere ai propri obblighi nei confronti degli studenti anche in pandemia, quando tanti licei prestigiosi e antichi non hanno potuto fare altro che chiudere? Certamente la sorte ci è stata favorevole, poiché abbiamo ereditato gli spazi di una gloriosa struttura alberghiera che fino agli anni ’80 ha ospitato nazionali di calcio, cantanti, kermesse politiche, e dunque disponiamo di spazi ampi, molti laboratori in cui dividere gli studenti di pratica, una consuetudine all’igiene che, già prassi ordinaria per chi manipola il cibo, ora è divenuta un’attività maniacale. Siamo proprietari della piattaforma di dad, e chi scrive ne è l’amministratore, quindi possiamo intervenire in tempo reale per risolvere le difficoltà che si presentano frequentemente, e il contenimento del digital divide realizzato con l’acquisto dei device (perdonate l’anglofilia informatica, ma devo essere all’altezza dei tempi) e della connessione ci ha perlomeno consentito di avere un canale diretto sempre aperto con tutti i ragazzi e le ragazze. Dimenticavo, sempre perché baciati dal fato, i banchi monoposto li abbiamo sempre avuti, forse come retaggio dell’impostazione paramilitare delle brigate di cucina, e ci siamo risparmiati l’orribile spettacolo della consegna di tali suppellettili, unica inutile spesa che a quanto pare è stata accordata per fronteggiare la situazione.
Fortuna? Buona amministrazione? Capacità didattica del corpo docente? Sicuramente ci siamo trovati nella possibilità di affrontare decorosamente la pandemia per una serie di circostanze direi quasi casuali e fortunate. Chi lavora nella mia scuola, già probabilmente motivato a concepire l’insegnamento come una sfida quotidiana e mai scontata, avendo scelto la formazione professionale che, come noto, non garantisce vita tranquilla, ha fino ad ora fatto la sua parte. Nessuno si è mai rifiutato di fare lezione da scuola, per garantire la presenza per i ragazzi con DSA; le nostre aule peraltro sono tutte attrezzate per la didattica mista, avendo un direttore con un background informatico, che ci ha dotati di maxi-schermi e microfoni ambientali.
Non siamo certo un’isola felice, ma qualche merito forse lo abbiamo avuto. Abituati ad affrontare asprezze di ogni genere, scuola di frontiera per vocazione e collocazione, non ci siamo trovati troppo scomodi nell’attraversare l’annus horribilis della pandemia. Non ci spaventa neanche l’eventuale prosecuzione dell’anno scolastico oltre i termini consueti, poiché il nostro ordinamento prevede che le ore previste debbano sempre essere concluse, e non è insolito proseguire fino a fine giugno, talvolta anche i primi di luglio, grondando di sudore e agognando le frescure che il mare a due passi ci promette. Gente dura insomma, noi del professionale, avvezza a sopportare ogni genere di angheria, soprattutto da parte di quei ragazzi e quelle ragazze che tanto amiamo, e per i quali cerchiamo di fare del nostro meglio per offrire loro un futuro.
Ma forse è proprio su questo slancio eroico, nel sacro fuoco dell’insegnante che si sostituisce al legislatore quando latita e non offre le giuste risposte, che l’ingranaggio si inceppa. Quanti dei pochi o tanti successi sono dovuti al sistema della formazione professionale, e quanti invece alla buona volontà di chi, nonostante il sistema stesso, cerca di fare del proprio meglio? Vorrei per un attimo scostarmi di lato per osservare la realtà in cui sono immerso, sapendo che così è possibile scorgere qualche crepa, che vorrei provare a osservare col disincanto del capomastro che sa quando un muro si può riparare, o non sia piuttosto il caso di buttarlo giù per ricostruirlo dalle fondamenta.
Innanzitutto occorre contestare l’idea che la formazione professionale sia, con i dovuti distinguo ed eccezioni, ancora considerata una scelta di scarso valore, un ripiego per chi, come diceva un vecchio adagio contadino, non avendo testa ha gambe. A quanti ragazzi e ragazze delle medie ancora consigliano di andare a fare il mestiere, di dedicarsi a qualcosa di pratico perché non si può cavare sangue dalle rape, e dunque inutile accanirsi con studi di poca sostanza, che non gioverebbero di certo al futuro del giovane e alle magnifiche sorti e progressive dell’economia del paese? Ecco, io vorrei prendere uno qualunque dei tanti solerti pedagogisti della zappa e del mattone, che si prodigano in consigli di buon senso suggerendo di continuare la scuola facendo qualcosa di manuale, e chiedergli se sarebbero in grado di capire quante conoscenze, quanto sapere antico e tecnologico, quanta passione e quanto lavoro servano per realizzare un piatto di successo. Quanto amore per l’arte e la chimica molecolare animi tanti e tante chef, quanto la conoscenza dell’intelligenza artificiale abbia sviluppato tecnologie degne dell’industria aerospaziale per costruire un forno di ultima generazione. Ragazzi con l’olfatto assoluto, di cui Suskind andrebbe fiero, in grado di stupire per la costanza e la passione che dedicano nel capire e nel creare le loro preparazioni culinarie. E per far ciò occorre viaggiare, studiare, amare il proprio percorso professionalizzante. Nella curiosità e nella gioia dei ragazzi di aprire una bottiglia di buon rosso invecchiato, che racconta storie di terre curate da secoli con sapienza, io rivedo lo stesso amore che animava me per lo studio della storia, dell’epica, dell’arte medievale. La differenza non sta negli studenti e nelle studentesse, dotati di intelligenza e capacità come chiunque altro; la differenza risiede nella prospettiva che offriamo loro. Possiamo contribuire a costruire uno splendido futuro per ragazzi e ragazze curiosi e preparati, il cui passaggio a scuola non è altro che una tappa delle tante che la vita regalerà loro, oppure possiamo pensare che l’unica redenzione possibile per chi arriva da noi, spesso provenendo dalla strada e dal colloquio con gli orientatori delle medie, sia trovare un lavoro il prima possibile, in una catena di montaggio dal sapore fordista, che anziché assemblare automobili assembla lasagne.
A chi giova tutto questo? È mai possibile ridurre il percorso scolastico degli adolescenti in una sorta di centro per l’impiego di lunga permanenza, da cui uscire solo per rimpinguare, nel migliore dei casi, le schiere dei lavoratori precari? I tre anni che passano qui da noi (perché dimenticavo di dirlo, la formazione professionale assolve l’obbligo scolastico fino ai sedici anni, dunque è triennale) possono essere pensati, gestiti e vissuti in modi diametralmente opposti: o si sceglie di scommettere sulla formazione a tutto tondo dei discenti, aprendo loro ogni orizzonte possibile, o si opta per una formazione tecnica essenziale e rapidamente spendibile, ma molto limitata. Forse è possibile immaginare una soluzione di compromesso, ma la sostanza non cambia. Il problema di fondo è in che modo il legislatore intenda concepire la formazione professionale in questo paese; a beneficio di chi va? Di chi frequenta i centri di formazione, o delle aziende che avranno manodopera qualificata con scarso potere contrattuale? A questo orizzonte di senso si somma di conseguenza l’investimento in termini di risorse e di personale, che in tanti centri ancora è assai stentato. Quanti insegnanti che lavorano nei CFP sono stabili? Su che risorse possono contare i CFP? Che potere negoziale hanno con il mondo del lavoro e delle imprese con cui devono entrare in una relazione sempre più stretta, dal momento che i terzi anni da noi realizzano stage da 500 ore?
Il mio pensiero non rappresenta di certo la totalità di coloro che lavorano nei CFP, anche perché il fin qui vituperato rapido ingresso nel mondo del lavoro ha rappresentato per molti davvero un’ancora di salvezza, una redenzione e un’opportunità straordinaria per giovani che hanno avuto in sorte l’essere nati nel paese con il welfare state più scarso d’Europa, e che attraverso di noi, e il lavoro trovato tramite gli stage, hanno potuto sostenere se stessi e le loro famiglie. Ma temo talvolta che chi lavora in queste scuole da anni, sia ormai rassegnato nell’accettare che il miglior risultato possibile sia diplomare onesti lavoratori e lavoratrici, e ogni tanto qualche fulgida eccezione di successo, quando invece potremmo avere la possibilità di ribaltare la prospettiva. Ciò sarebbe possibile se la governance della formazione professionale in Italia si rifiutasse di essere prona alle richieste del mercato, quali esse siano, e investisse seriamente in percorsi di studi che possano proseguire oltre il diploma di qualifica, e che comunque contemplino nella programmazione didattica un livello di conoscenze adeguato. Badate bene che come si pensa che uno studente o una studentessa del liceo classico debbano avere capacità critica e un sapere ampio, lo stesso dovrebbe valere per chi frequenta i CFP. Davvero pensate che solo chi fa il classico possa entusiasmarsi di fronte alla maestà delle biblioteche antiche di Roma, restare senza fiato di fronte al trompe l’oeil della volta di Sant’Ignazio, o emozionarsi nel tradurre lettere di missionari gesuiti che i primi anni del’600 fuggivano dalle loro terre? Chi scrive è testimone del contrario. Ho viaggiato in Europa con gli studenti e le studentesse della propria scuola, ammirando i bastioni di Cadice come la Paella Valenciana, l’antica facciata di Alcalà de Henares come la cola de toro; abbiamo pianto a Birkenau, ci siamo avventurati nelle gole tufacee etrusche, che ironia della sorte si chiamano col nome caro agli specialisti dei secondi piatti, tagliate. Abbiamo fatto tutto quello che ogni studente d’Italia, di qualunque indirizzo di studi, avrebbe fatto. La differenza, ripeto, non sta in loro, ma in noi. Ed è con questa responsabilità che dobbiamo lavorare. Facciamo carta straccia del comodo alibi offerto dal pensare che per alcuni lo studio sia tempo perso, e cerchiamo di ricordare le lezioni sulla maieutica che forse abbiamo ascoltato troppo distrattamente. Una delle gioie maggiori è scoprire talenti, passioni, capacità negli studenti e nelle studentesse, che fino a quel momento erano stati sepolti sotto la terra arida dello sbocco professionale, frettolosamente giudicati inabili allo studio spesso perché incappati in sistemi scolastici inadeguati a esplorare il loro mondo interiore e le loro certamente numerose vocazioni. E ricordando comunque che, come accennavo in principio, nel cibo e nel suo rapporto con l’uomo c’è un universo di sapienza che davvero vale la pena di esplorare a fondo.
Dunque, quale che sia l’indirizzo di studi, il compito dell’insegnante dovrebbe rimanere lo stesso; educare, nel senso etimologicamente più corretto del termine, portare fuori da. E anche il legislatore farebbe bene a ricordare tutto questo".
Livio Ciappetta
(Livio Ciappetta è coordinatore didattico del nostro Centro di formazione professionale alberghiero di Castelfusano, oltre che storico dell’età moderna e autore di saggi dedicati alla storia dell’Inquisizione spagnola e alla didattica della storia)
L'articolo è tratto dal blog "Il primo amore", www.ilprimoamore.com